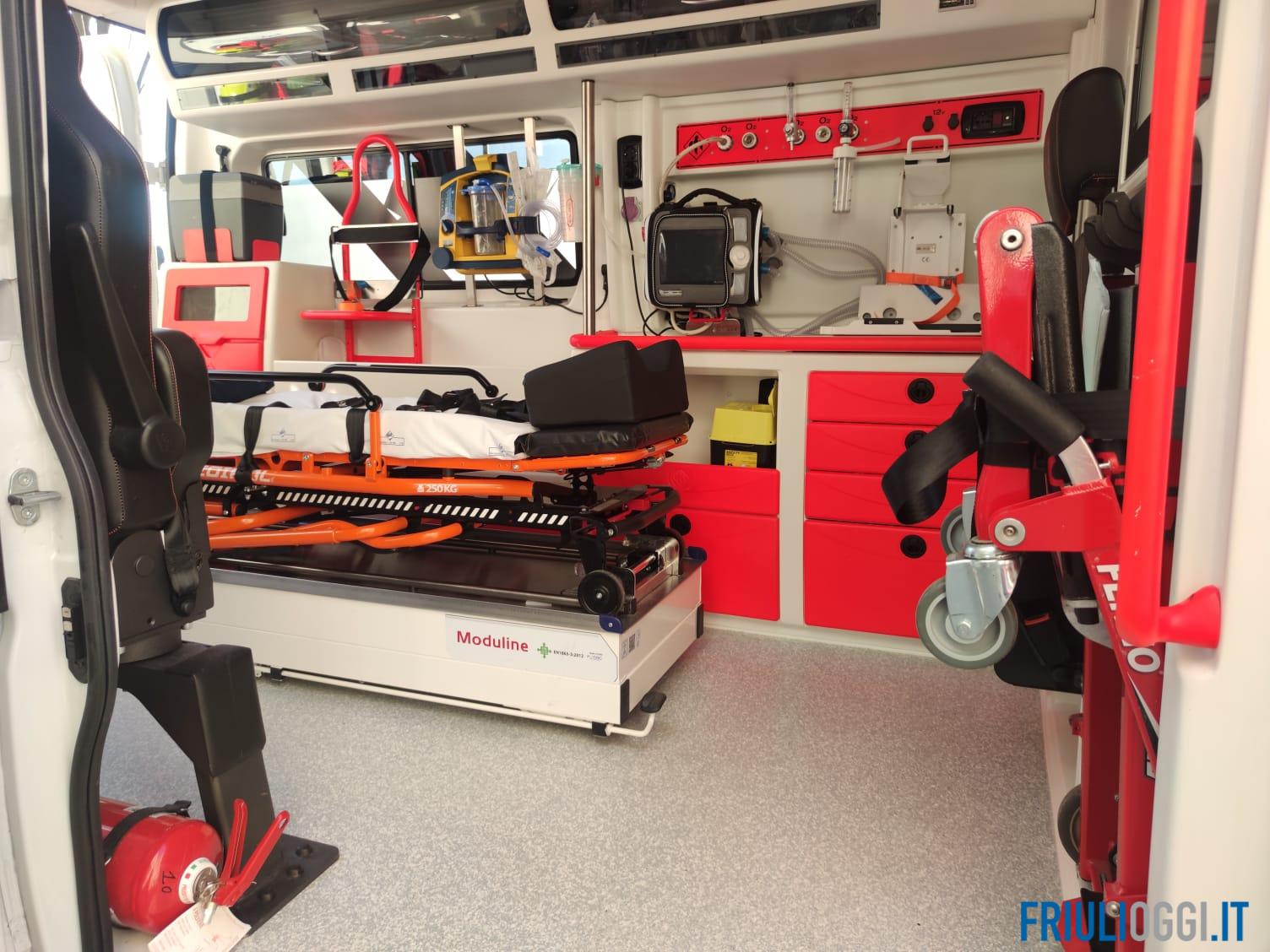Un documentario dedicato ai Magredi del Friuli.
Un tappeto di ciottoli bianchi, impreziosito qua e là da cespugli e fioriture dai colori accesi; una distesa ghiaiosa, arida e povera di nutrienti, ma anche centro di un ecosistema unico e ricchissimo di biodiversità: sono i contrasti a rappresentare i Magredi, termine usato per definire le praterie magre presenti nell’alta pianura friulana: un territorio che appare freddo e improduttivo, ma dove la varietà floristica si mostra e diventa risorsa in termini di fieno, fiorume, polline e nettare di fiori necessari a sostenere la presenza degli impollinatori.
Un documentario dedicato a questo peculiare ecosistema.
Il paesaggio, la storia naturale, la biodiversità dei Magredi – tra i prati stabili più ricchi di specie a livello nazionale e continentale – verranno raccontati nel documentario “Magredi, la steppa friulana”, realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del progetto Life Pollinaction.
Il prodotto cinematografico (regia di Ivo Pecile e Marco Virgilio, sceneggiatura di Stefano Fabian) verrà proiettato il 9 aprile al cinema Visionario di Udine e il 10 aprile al Cinemazero di Pordenone (entrambi gli appuntamenti alle 20.30).
L’evoluzione dei Magredi.
Immerso nelle suggestive immagini delle lande steppiche friulane incastrate tra i torrenti Cellina e Meduna, e lungo il Tagliamento, lo spettatore si troverà a passeggiare tra i Magredi in compagnia di uomini e donne legate, ognuno a suo modo, a questo incredibile territorio, originato dalla capacità erosiva e di trasporto dei torrenti fluvioglaciali.
Si tornerà indietro nel tempo con i ricordi di Rina Del Zotto e Graziano Ambroset, custodi della memoria delle antiche pratiche agricole utilizzate per conservare, mantenere e gestire i Magredi. Storicamente è stato l’uomo a impedire l’evoluzione di queste aree verso il bosco attraverso l’attività di sfalcio, pascolo e raccolta del legname.
Poi il mutamento del quadro socioeconomico, con il cambiamento dell’agricoltura e delle forme di allevamento, ha portato al progressivo abbandono dei prati meno produttivi e al disinteresse verso lo sfalcio dei prati stabili in quanto poveri di sostanze nutritive, ma ricchi in termini di specie floristiche.
Il futuro della “steppa friulana”.
Cercare di riconnettere la gestione e la conservazione dei Magredi diventa oggi una necessità. Come farlo? Con le forme di agricoltura più tradizionali e di allevamento estensivo e pascolo ovino transumante recuperate in chiave moderna e con un occhio di riguardo verso la qualità dei prodotti, un’alimentazione più sana e una maggiore ecosostenibilità del processo produttivo.
Caterina De Boni, pastora di professione, racconterà la sua iniziativa – realizzata in collaborazione con il Servizio Biodiversità della Direzione Risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione – e della funzione di presidio del territorio che il pascolo estensivo può rappresentare, se regolato e ben attuato, contrastando con la sua presenza i fenomeni di abbandono e salvaguardando biodiversità e paesaggio.
I progetti di tutela.
Prima con il Progetto Life Magredi Grasslands poi con il Progetto Life PollinAction, la Regione ha infatti posto l’attenzione sui prati stabili, considerati i principali capisaldi ecologici per il sostegno delle “reti di impollinazione”, cioè l’insieme di insetti indispensabili per le piante selvatiche e per l’agricoltura, ripristinando oltre 600 ettari di prati magri su territori sfruttati e poi abbandonati dall’agricoltura intensiva.
Il Progetto Life PollinAction, in fase di conclusione, in particolare ha puntato sul recupero e il miglioramento dei prati degradati, attraverso la distribuzione di oltre 200 quintali di fiorume e la messa a dimora di più di 100mila piantine. Il focus si è poi spostato sul supporto alla comunità di impollinatori, con la creazione di siepi mellifere (prodotte con 28.200 arbusti distribuiti su oltre 3,5 chilometri) e di fasce fiorite (in particolare nei Bastioni di Palmanova, con 150 chilogrammi di seme in purezza di specie selvatiche).
Accanto a queste azioni, il Progetto si è dedicato all’ideazione delle Filiere dei prati stabili presenti in regione. Una novità nel panorama italiano, volta a sostenere la nascita di filiere corte in grado di utilizzare le risorse di cui sono ricchi i prati stabili (si pensi al fieno e al fiorume) in un’ottica di economia circolare e sostenibile. La finalità del progetto di Filiera è sfruttare al meglio e proteggere queste formazioni erbacee, ma anche promuovere le grandi opportunità legate alla valorizzazione del paesaggio, delle tradizioni e dei prodotti locali ad essi collegati.
Economicamente questi prati, come emerge nel docufilm dalle testimonianze di Graziano Zanello, titolare di un’azienda agricola biologica, e del casaro Roland Pressacco, possono divenire centrali per la produzione di foraggio, che sta alla base di filiere di prodotti di qualità come latte, formaggi, carne, ma pure fiorume per i ripristini naturalistici o miele per l’apicoltura.
Il documentario infine andrà a toccare l’esperienza di vita di Alfio Scandurra che, con il suo asinello Fiocco, ha attraversato in lungo e largo i Magredi (“Mi sembra di stare nel posto migliore del mondo”, aveva scritto in suo libro) lanciandosi in viaggi slow accompagnati solo dal silenzio della natura. Gli itinerari percorsi e il modo innovativo di scoprire i luoghi di casa nostra hanno messo in risalto il legame non solo fisico ed ecologico dei magredi con le retrostanti montagne, ma anche il rapporto che potrebbe nascere attraverso forme di fruizione, basate sulla conoscenza naturalistica e la pratica di un trekking a passo lento, che favoriscono il contatto profondo con il territorio.